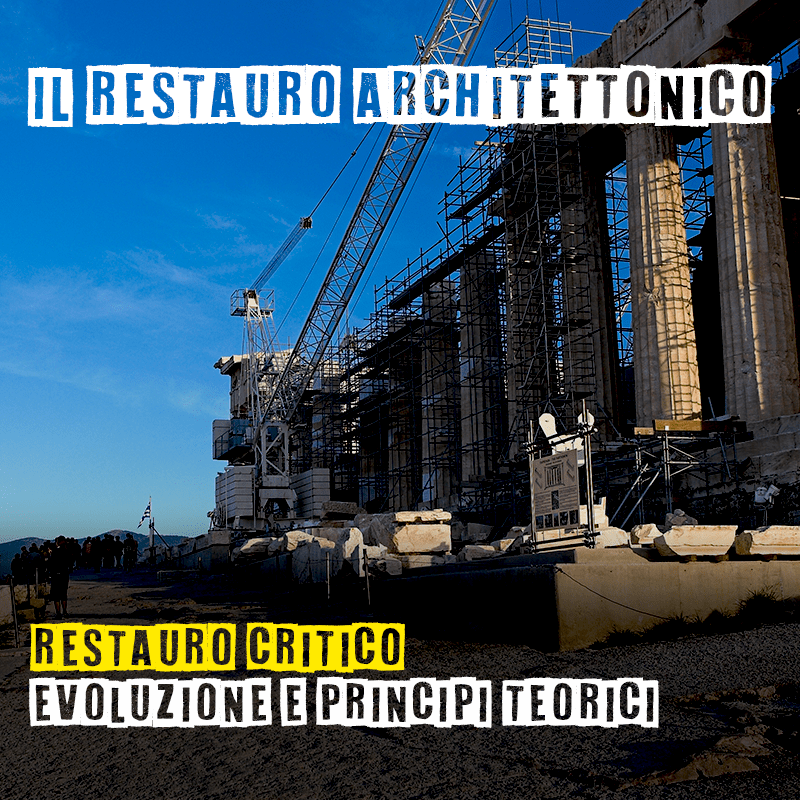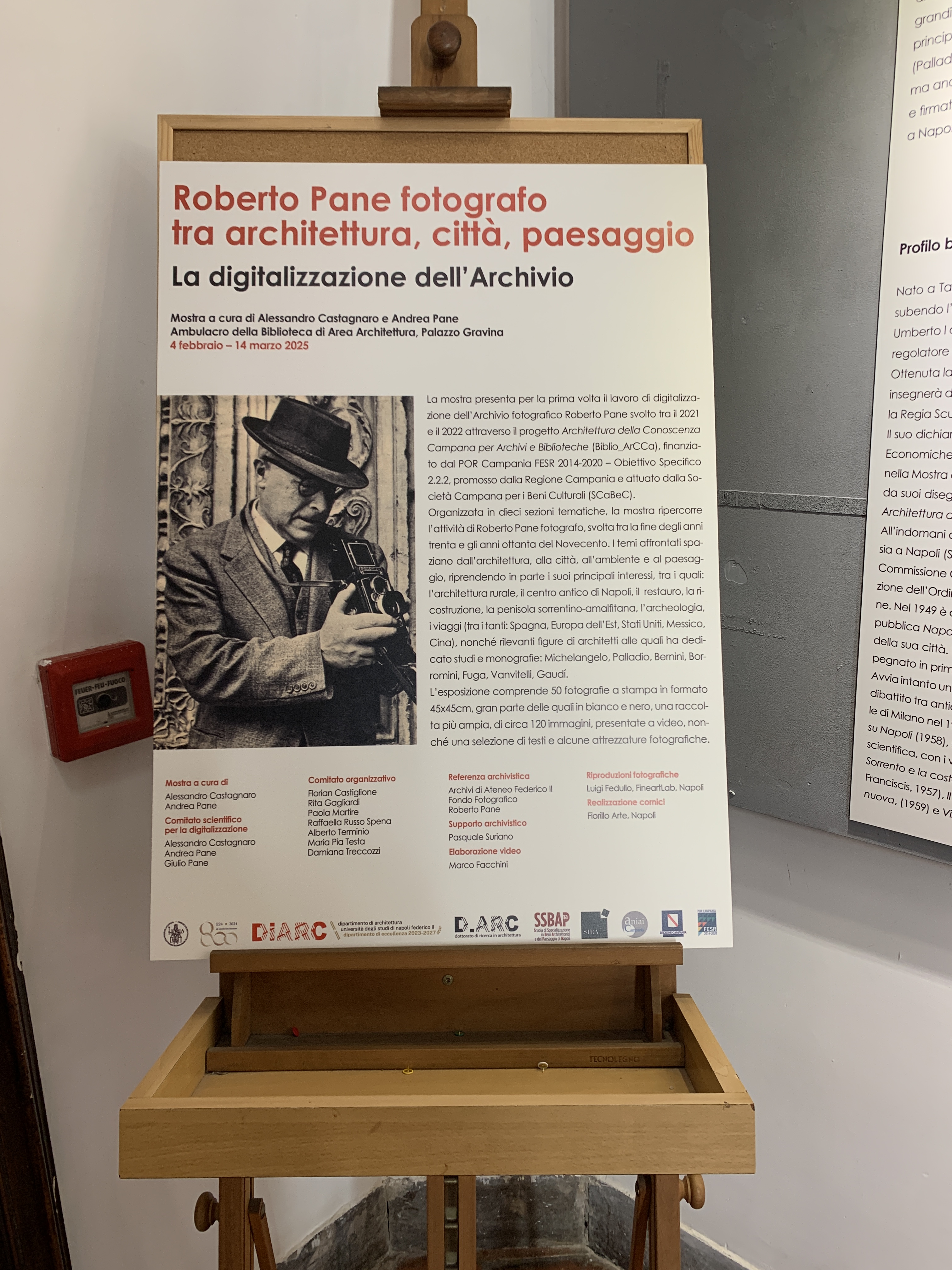Abstract
Una riflessione sul valore etico delle rovine come strumenti di memoria storica e civile. Al centro, la scelta di conservare una struttura distrutta dalla guerra come testimonianza viva e silenziosa di ciò che è stato. L’architettura, non restaurata ma mantenuta nella sua vulnerabilità, diventa documento e monito. Attraverso esempi emblematici come Hiroshima, Oradour-sur-Glane, Berlino, Coventry e Dresda, si esplora il potere della rovina di trasmettere consapevolezza, educare alla pace e opporsi all’oblio. Una meditazione sul ruolo del restauro e sull’importanza di lasciare visibili le ferite della storia.

Conoscere vuol dire evitare: il messaggio di Hiroshima (Genbaku Dome) – Il Restauro Architettonico







Io sono Vincenzo Biancamano, architetto esperto in restauro e questo è Il Restauro Architettonico, seguimi sui nostri canali social Facebook, Instagram, YouTube , iscriviti e attiva la campanella. L’episodio di oggi è speciale. Una riflessione sul potere della rovina, sull’architettura non restaurata ma lasciata in piedi per raccontare. Ottant’anni fa, il 6 agosto 1945, Hiroshima fu distrutta da una bomba atomica. Eppure, in quel nulla, rimase in piedi la Cupola della Bomba Atomica.Non fu ricostruita, demolita, ma lasciata così. A dire. A ricordare. In questo episodio attraverseremo la sua storia, la scelta di conservarla come rovina, e il dialogo silenzioso con il Museo della Pace e la Fiamma nel Parco, che arderà fino alla scomparsa delle armi nucleari. Una puntata che è anche un invito. A vedere, sapere, non dimenticare. Perché conoscere vuol dire evitare. E la memoria è la cosa più preziosa da tramandare.
Iscriviti alla newsletter
Inserisci la tua e-mail di seguito per ricevere gli aggiornamenti.
Ricordo la prima volta che vidi l’immagine della Cupola di Hiroshima. Benché non sia mai stato in Giappone, mi sembrava di conoscerla da sempre. Quel rudere, sospeso tra distruzione e memoria, mi parlava senza parole. Come architetto, ho sempre pensato che le rovine avessero un linguaggio muto, fatto di materia e vuoto. Ma la Cupola della Bomba Atomica ha qualcosa di diverso: racconta la tragedia e la speranza nello stesso istante. Immagino di camminare lungo il fiume Motoyasu, di avvicinarmi a quel guscio spoglio e di posare la mano su uno dei suoi mattoni bruciati. Forse sentirei ancora il calore di quel giorno, o forse solo il silenzio di chi ha scelto di non dimenticare.
Spoglia, muta, eppure eloquente. La Cupola della Bomba Atomica si erge come un guscio svuotato, uno scheletro architettonico che trattiene il respiro della storia. La sua struttura ottagonale in mattoni rossi, annerita dal fuoco e screpolata dalle onde d’urto, si apre al cielo attraverso finestre ad arco, prive di infissi e vetri.
In cima, la cupola metallica contorta, un tempo coperta da rame, appare come una rete spezzata, deformata dal calore e sospesa nel vuoto: un ricamo di ferro ossidato che vibra nel silenzio.Intorno, le murature spezzate, le crepe profonde, le superfici segnate dal tempo e dalle intemperie, raccontano la fragilità della materia e la resistenza della testimonianza.
Questa rovina non è pittoresca: è scarna, violata, irregolare. Non consola, ma obbliga a guardare. E nella sua asimmetria lacerata, nella matericità cruda di mattoni, ferri e superfici bruciate, è immagine viva del trauma e icona del ricordo.
All’ombra di una struttura di mattoni sventrata e di un’intelaiatura metallica ricurva, la Cupola della Bomba Atomica di Hiroshima si erge silenziosa sulle rive del fiume Motoyasu. Prima di diventare un rudere emblematico, questo edificio era una sala espositiva. Fu progettato dall’architetto ceco Jan Letzel e completato nel 1915 come Sala Espositiva Commerciale della Prefettura di Hiroshima, dotata di una cupola ovale in rame verde ossidato. Con il suo stile europeo, divenne un luogo di prestigio per fiere di prodotti locali, mostre d’arte ed eventi commerciali, tanto che nel 1933 venne ribattezzato Sala della Promozione Industriale. In quegli anni, la cupola di rame luccicante dominava il profilo urbano di Hiroshima, simboleggiando modernità e orgoglio cittadino.
Tutto cambiò la mattina del 6 agosto 1945. Alle 8:15 il bombardiere americano Enola Gay sganciò la bomba atomica “Little Boy” su Hiroshima. In un istante, la città fu devastata. L’edificio di Letzel, a 160 metri dall’epicentro, fu colpitoda un’energia indescrivibile. L’onda di calore di migliaia di gradi fuse la copertura di rame della cupola e incendiò il tetto; l’esplosione avvenne quasi sopra la struttura, incanalando la deflagrazione verso il basso: l’interno fu annientato, ma le mura perimetrali resistettero. I pochi dentro morirono sul colpo, così come decine di migliaia di persone. Nel raggio di due chilometri non rimase quasi nulla in piedi. Eppure, tra macerie fumanti e scheletri, quella cupola spezzata rimase, come un sopravvissuto alla catastrofe. L’imponente palazzo di mattoni era ridotto a scheletro, con le travi metalliche contorte che spiccavano verso il cielo vuoto. In mezzo a un panorama di ceneri e rovine, la Sala della Promozione Industriale divenne Genbaku Dome, la “Cupola della Bomba Atomica” – l’unico edificio rimasto vicino all’epicentro.
Subito dopo l’esplosione, Hiroshima era distrutta. I pochi superstiti camminavano tra le macerie, assetati e feriti, sotto una “pioggia nera” radioattiva. Akiko Takakura, diciannovenne, ricorda nel suo diario: «Dopo un po’ iniziò a piovere… una pioggia nera, a gocce grosse». Quella di fuliggine e residui radioattivi bagnò le rovine della cupola, macchiando i suoi muri di cenere. In quel luogo tutto era distrutto; solo la Cupola rimase, silenziosa testimone di una devastazione inaudita.
Ogni volta che mi trovo davanti a una rovina, mi chiedo: cosa vogliono raccontarmi queste pietre? La Cupola di Hiroshima sembra rispondere a questa domanda con una chiarezza spietata. Non esiste restauro che possa cancellare la memoria di ciò che è accaduto. E forse è giusto così. In un mondo in cui tutto si rigenera, si rifà, si cancella, quella Cupola ci insegna che ci sono ferite che devono restare aperte. Non per alimentare l’odio, ma per nutrire la consapevolezza.
Nel dopoguerra, Hiroshima affrontò un dilemma: cosa fare della struttura mutilata nel centro raso al suolo? Molti residenti traumatizzati volevano abbattere ciò che consideravano un triste ricordo del giorno più terribile della loro vita. La Cupola ricordava continuamente la tragedia; c’era chi preferiva cancellarla, ricostruire tutto da zero e dimenticare. Eppure, nei primi anni ’50, emerse un sentimento opposto, soprattutto tra i giovani: preservare la Cupola così com’era, come rovina e memoriale, affinché il mondo non dimenticasse l’orrore della bomba atomica. Studenti delle superiori e cittadini comuni si mobilitarono, raccogliando firme e fondi per salvarla. La loro voce sosteneva che la rovina doveva restare in piedi come monito della distruzione nucleare.
Nel 1966, il Consiglio Comunale di Hiroshima decise di non demolire la Cupola, ma di consolidarla e conservarla in perpetuo. Iniziò un’opera di messa in sicurezza e manutenzione (1967, 1989, 2002, 2015) per mantenere la struttura nelle condizioni post-esplosione. Il Giappone scelse di non ricostruire quel rudere. Attorno ad esso sorse il nuovo Parco Memoriale della Pace, ma la Cupola rimase intoccabile, protetta da progetti di sviluppo urbano. Quella ferita nel cuore della città divenne un santuario laico della memoria. I resti degli altri edifici furono abbattuti durante la ricostruzione postbellica, ma la ex Sala Espositiva – a 160 metri dal “ground zero” – fu lasciata, “così come si trovava dopo l’esplosione”, simbolo di pace e ricordo dell’attacco atomico. Dal 1996, questa rovina è nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, riconosciuta come patrimonio dell’umanità da preservare.
La decisione di mantenere la Cupola in rovina derivava dalla convinzione che la memoria visibile di Hiroshima dovesse prevalere sull’oblio. Nel Giappone del dopoguerra, in piena occupazione americana, la città abbracciò la nuova identità di “Città della Pace”, trasformando il luogo più devastato in uno spazio di ricordo e monito per il futuro. Nel 1949 una legge proclamò Hiroshima “Città Memoriale di Pace” e destinò fondi alla sua ricostruzione. Fu un caso unico: rinunciare a ricostruire interi quartieri in un’area centralissima per un parco della memoria. Questa scelta rifletteva il desiderio dei sopravvissuti: trasformare le macerie in speranza, fare della città un messaggio vivente di pace. Decisedi colmare la ferita con un omaggio alla pace, ricostruendo tutto intorno ma mantenendo quel vuoto al centro, affinché il sacrificio non fosse dimenticato. In altre città devastate dalla guerra, come Tokyo, prevalsero logiche diverse: si cancellarono i segni dei bombardamenti e non si crearono grandi memoriali pubblici. Il contrasto è significativo: due giapponesi, una a ricordare, l’altra a dimenticare, dimostrano che le scelte di ricostruzione dopo una guerra sono politiche e ideali. Hiroshima, scegliendo la memoria, si candidò a simbolo internazionale della rinascita pacifica, mentre la Cupola, lasciata dov’era, divenne il simbolo silenzioso della volontà di non ripetere quell’errore.
Viviamo in un tempo in cui la minaccia nucleare sembra più lontana, eppure, come architetto e come uomo, sento il dovere di non dimenticare. La Cupola di Hiroshima non è solo un monumento: è un ammonimento. Mi chiedo spesso se sapremo custodire questo messaggio, se sapremo vedere in quella rovina non solo il passato, ma anche un avvertimento per il presente e il futuro. Per me, guardare quella Cupola significa osservare il limite estremo dell’azione umana – e, al tempo stesso, la possibilità di scegliere un altro cammino.
Nel corso dei decenni, la Genbaku Dome ha assunto un significato universale come monumento alla memoria. Inizialmente era un ricordo difficile per i cittadini di Hiroshima, il luogo dove ricordavano i loro cari scomparsi. Ma con la diffusione dell’orrore atomico, la Cupola sventrata è diventata un simbolo globale. Visitatori da ogni paese, leader mondiali e personalità religiose – tutti in visita a Hiroshima – hanno sostato in silenzio davanti a quel che resta della Cupola. Nel 1996, con l’iscrizione nel Patrimonio UNESCO, è stato riconosciuto che “non solo rappresenta in modo crudo e potente la forza distruttiva più terribile mai creata dall’umanità, ma esprime anche la speranza per una pace mondiale duratura e per l’eliminazione totale delle armi nucleari”. Da reliquia locale, è diventata un emblema globale: la sua immagine appare nei libri di storia, nei documentari, nelle campagne per il disarmo. Chiunque la osservi comprende, senza parole, il messaggio che incarna. Come recita la targa UNESCO, essa è «l’unica struttura rimasta in piedi nei pressi dell’esplosione della prima bomba atomica il 6 agosto 1945» ed è conservata “nello stesso stato dopo il bombardamento”, a monito dell’enorme devastazione. Il suo valore risiede in ciò che simbolizza, più che nei suoi aspetti architettonici: la Cupola è la forma scheletrica di un edificio sopravvissuto, un testimone che sottolineal’importanza della pace e l’urgenza di eliminare gli armamenti atomici.
Ogni anno, il 6 agosto, Hiroshima ricorda le sue vittime con una cerimonia nel Parco della Pace. All’alba risuonano rintocchi di campana, poi alle 8:15 – l’ora dello scoppio – la città osserva un minuto di silenzio mentre vengono liberate colombe bianche. Di fronte al cenotafio, allineato con la Cupola, vengono deposte ghirlande e offerte preghiere. Sul cenotafio è incisa una dedica: «Possano tutte le anime delle vittime riposare in pace, poiché non ripeteremo mai più questo errore». Questa iscrizione – “Noi non ripeteremo l’errore” – indica la volontà di fare della memoria un impegno morale per il futuro dell’umanità. La Cupola, presenza silenziosa e significativa, è lì per ricordare quell’impegno. Nell’ombra delle sue rovine, si avverte un messaggio di pace universale: mai più una città annientata dal fuoco nucleare. Così, da simbolo del dolore di Hiroshima, la Cupola è divenuta simbolo del dolore di tutte le guerre e di speranza in un mondo libero dall’incubo atomico.
Nel Parco Memoriale della Pace di Hiroshima, la Cupola occupa l’estremità nord, sulla riva del fiume, mentre all’estremità opposta sorge il Museo Memoriale della Pace. Tra di loro, sull’asse centrale, si trovano la Fiamma della Pace e il Cenotafio, allineati in modo che, attraverso l’arco del cenotafio, si veda la Cupola. Questo allineamento fu concepito dall’architetto giapponese Kenzo Tange, che nel 1949 vinse il concorso per il progetto del Parco. Tange immaginò il parco come un percorso per i visitatori dal verde e dalla quiete verso la realtà della memoria, preparando l’animo prima del confronto con le testimonianze nel museo. L’asse nord-sud che collega la Cupola al Museo, passando per il cenotafio, simboleggia il legame tra il luogo della distruzione e lo spazio della memoria e dell’educazione. In una lettera dell’epoca, Tange descrisse il parco come “una base per le attività per la pace”: la Cupola in rovina fu utilizzata come fulcro simbolico del progetto, a indicare da dove nasce il percorso – dal ricordo del disastro – e verso dove deve andare – verso l’apprendimento e la consapevolezza, simboleggiati dal museo.
Il Museo Memoriale della Pace di Hiroshima, aperto nel 1955 e progettato da Tange, è carico di significati simbolici: è formato da un corpo principale rettangolare rialzato su pilastri, che sembra fluttuare sopra un vasto spazio aperto. Lascelta architettonica di sollevare la struttura – lasciando libero il piano terreno – evoca leggerezza e rinascita (l’edificio che si eleva sopra la terra bruciata), e richiama la tradizione giapponese (i granai su palafitte, sollevati dal suolo). Tange spiegò che voleva “mostrare la forza dell’uomo nel superare il disastro e la rovina”. Chi visita oggi il museo non coglie subito tali riferimenti, ma ne percepisce l’effetto: l’atrio sotto l’edificio è ampio, luminoso, attraversato dalla brezza – uno spazio di respiro prima delle sale dell’esposizione. Funge anche da portale cerimoniale: è l’ingresso al Viale della Pace, che conduce dritto verso la fiamma e il cenotafio. L’architettura dialoga silenziosamente con la Cupola: quella rimane una ferita nel paesaggio, questo – il museo – è un luogo per dare senso a quella ferita, attraverso la comprensione e la conoscenza.
All’interno del Museo della Pace, il visitatore intraprende un percorso emotivamente coinvolgente. Le prime sale illustrano la storia di Hiroshima prima e dopo la bomba attraverso pannelli, fotografie e filmati. Prima del 1945, la città era una comunità viva e fiorente, fondamentale per comprendere cosa andò perduto in pochi secondi. Poi, si entra nel cuore dell’esposizione, nelle sale penombrate con i reperti originali del 6 agosto 1945. Oggetti comuni, testimonianze mute della catastrofe: un orologio da polso fermo alle 8:15, vestiti di studenti ridotti a brandelli bruciati, bottiglie di vetro fuse, travi metalliche contorte, tegole vetrificate, cicatrici su lastre di pietra. Uno degli oggetti più impressionanti è la famosa “ombra” di Hiroshima: il contorno di un essere umano evaporato dall’esplosione, rimasto impresso sui gradini di una banca – negativo fotografico di una presenza svanita. Di fronte a reperti come questi, molti visitatori restano in silenzio, incapaci di trovare parole.
Il museo presenta testimonianze dirette. Ci sono fotografie scattate nei giorni successivi, che mostrano una città spettrale popolata da sopravvissuti ustionati, dalla pelle penzolante, che vagano tra macerie e cadaveri. Ci sono diorami e ricostruzioni multimediali che mostrano la scala della distruzione. E soprattutto, ci sono video e audio con le voci degli hibakusha, che raccontano in prima persona ciò che videro e provarono quel giorno. Le loro parole, cariche di emozione trattenuta, rendono il dolore tangibile. Alcuni rievocano il momento del lampo abbagliante, seguito da un’onda d’urto che scaraventò tutti a terra. Altri descrivono il “vortice di fuoco” che inghiottì la città, e quella pioggia nera appiccicosa. “Era un inferno”, dicono – e ascoltando le voci rotte, il visitatore percepisce un frammento di quell’inferno. In una poesia esposta, la sopravvissuta Akiko Takakura scrive: “A più di cinquant’anni di distanza ricordo ancora quella fiamma blu, e il mio cuore quasi scoppia dal dolore”. È difficile trattenere le lacrime di fronte a testimonianze così dirette.
Il percorso museale promuove compassione e riflessione, non odio o risentimento. Un visitatore italiano ha osservato:“qui non si percepisce rancore, ma solo un inno alla pace”. Il Museo della Pace – pur documentando la distruzione causata dalla guerra – vuole essere un luogo educativo e pacifista, non un museo bellico. L’ultima sezione è dedicata al mondo dopo Hiroshima: mostra gli sforzi internazionali per il disarmo e le voci contro le armi nucleari. Citazioni di Madre Teresa di Calcutta, Dalai Lama, Jimmy Carter, Michail Gorbaciov e altri, con appelli alla pace e alla fratellanza. Il percorso si chiude proiettando il visitatore verso l’impegno di evitare che quanto accaduto a Hiroshima “non accada mai più, in nessun luogo”. Uscendo, molti rimangono in silenzio nell’atrio, osservando la Cupola attraverso le vetrate. Quella sagoma di rovine, vista dopo il carico emotivo del museo, appare sotto una luce diversa: non più un rudere storico, ma un simbolo vivo, a cui rendere omaggio e ricevere un messaggio significativo.
La scelta di non restaurare la Cupola di Hiroshima, ma di lasciarla com’era dopo l’esplosione, solleva riflessioni sul ruolo dell’architettura nella memoria collettiva. Di fronte a un edificio danneggiato, l’istinto sarebbe di ripararlo, ricostruirlo, cancellarne le ferite. Ma quando diventa un documento storico, portatore di un trauma da ricordare, mantenere intatte le sue cicatrici acquista valore. La Cupola è l’esempio più emblematico: la sua rovina inalterata è un racconto silenzioso, più eloquente di qualunque discorso. Ogni crepa nei muri, ogni trave annerita, ogni frammento pendente testimonia ciò che accadde alle 8:15 del 6 agosto 1945. È come se le pietre parlassero, mostrando al mondo la cicatrice di una città e, in senso figurato, dell’umanità.
L’architettura non è solo sfondo o contenitore della memoria – è memoria incarnata. La Cupola di Hiroshima rappresenta un monumento peculiare: un monumento per assenza. Non celebra una vittoria né abbellisce un viale trionfale; consiste in ciò che manca – il tetto crollato, i solai dissolti, la vita perduta. Quell’assenza diventa presenza potentissima. Guardando la Cupola, si visualizza l’istantanea dell’esplosione: il cielo bianco, l’onda d’urto che spazza via tutto tranne quei muri. La rovina comunica l’evento con un’immediatezza che nessuna ricostruzione ideale potrebbe rendere. C’è un termine giapponese, wabi-sabi, che indica la bellezza delle cose imperfette, impermanenti, segnate dal tempo. La Cupola, benché tragica, possiede un wabi-sabi nella sua austerità spoglia: bella non in senso estetico tradizionale, ma perché autentica, vera. È rimasta nuda e vulnerabile di fronte agli occhi di tutti, anno dopo anno, stagione dopo stagione, a raccontare la sua storia senza parole.
Lasciare visibili le ferite attraverso l’architettura ha un valore etico. Significa non nascondere il passato, ma affrontarlo.A Hiroshima, la Cupola è un memento: ricorda ai cittadini e ai visitatori l’impegno di evitare la ripetizione. L’architettura della rovina funge da coscienza visibile. Un edificio ricostruito avrebbe permesso di voltare pagina più facilmente, ma mantenere la rovina ha costretto generazioni a convivere con la memoria attiva della tragedia, integrandola nella propria identità civica. Non è semplice: significa portare il peso di quel ricordo. Negli ultimi decenni,Hiroshima ha dovuto lavorare su di sé, elaborare il lutto collettivo e trasformare il dolore in un messaggio di pace. La Cupola, da simbolo di sconfitta e disperazione, è diventata simbolo di rinascita morale. Invece di vendetta o odio, la sua presenza austera ispira pace e riconciliazione. Questo miracolo di semantica e sentimenti è stato possibile lasciando la ferita aperta ma non infetta: è stata messa in sicurezza (affinché non crolli), ma non “guarita” visivamente. Rimane lì, eterna convalescente, a ricordarci che alcune non vanno rimarginate del tutto – vanno tenute a vista, affinché chi le osserva capisca e cambi.
Hiroshima offre una lezione unica sul ruolo dell’architettura nella memoria storica. Un edificio non deve essere “utile” per testimoniare. La Cupola inutilizzabile è fondamentale per la coscienza umana. Ogni crepa è un monito, ogni frammento è una lezione. Dopo Hiroshima, alcuni medici decisero di conservare su lastre fotografiche le immagini delle cicatrici degli hibakusha – come le cheloidi da ustione atomica. Erano ferite mostruose, ma documentarle era essenziale per capire gli effetti della bomba. La Cupola è una cicatrice urbana esposta: brucia ancora allo sguardo, ma è significativa. È una scelta coraggiosa – il coraggio di non distogliere lo sguardo dal dolore – che porta a una catarsi collettiva: guardare quella rovina, ascoltarne il silenzio assordante, e promettere di non permettere mai più una simile devastazione.
L’idea di preservare la rovina architettonica come memoriale non è unica di Hiroshima. Ci sono luoghi dove strutture distrutte da guerre o violenze sono state mantenute intatte per testimoniare gli orrori del passato. Un viaggio tra questi “monumenti in rovina” mostra intenti e significati simili, nonostante le diverse vicende storiche.
Le rovine di Oradour-sur-Glane in Francia, il “villaggio martire” distrutto nel 1944 e conservato come memoriale.
Oradour-sur-Glane, in Francia, è un caso noto. È un villaggio vicino a Limoges che, il 10 giugno 1944, fu teatro di un massacro da parte delle truppe naziste. In poche ore, i soldati della 2ª Divisione SS Das Reich sterminarono 642 civili (circa 200 bambini), radunando uomini, donne e bambini e trucidandoli a colpi di mitragliatrice e fuoco – chiudendo le donne e i piccoli nella chiesa e dandole fuoco. Al termine dell’eccidio, il villaggio fu incendiato e raso al suolo. Al sopraggiungere della liberazione, il generale Charles de Gaulle visitò il sito e decise che Oradour non doveva essere ricostruito: le rovine sarebbero rimaste esattamente com’erano, a imperituro ricordo della ferocia nazista. Oggi,visitando Oradour-sur-Glane, sembra di trovarsi nel 1944: le case in pietra sono bruciate e sventrate, con gli interniesposti; auto carbonizzate giacciono arrugginite lungo le strade, la pompa di benzina del distributore è ancora al suo posto, deformata dal calore. All’ingresso un cartello accoglie i visitatori con una sola parola: “Souviens-toi” – “Ricorda”. Il silenzio regna tra i resti di negozi, caffè, officine; su alcuni edifici ci sono targhe con i nomi delle famiglie e le loro professioni. Nel cimitero, una lapide elenca i nomi delle vittime di quel giorno. Visitare Oradour è impressionante: sembra che il tempo si sia fermato. Quello che era un tranquillo paesino rurale è oggi un museo a cielo aperto della barbarie. Come ha scritto un cronista, Oradour è “una agghiacciante incarnazione della brutalità e dell’insensatezza della guerra”. Le rovine parlano da sole; la decisione di de Gaulle di preservarle ha fatto sì che generazioni di francesi – in particolare scolaresche – le visitassero come tappa obbligata di memoria storica. Il villaggio è stato dichiarato “Villaggio Martire” e monumento storico: non una celebrazione, ma un monito tangibile di ciò che il fanatismo e la violenza possono infliggere.
Un altro esempio emblematico è la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche di Berlino, nota come Chiesa della Rimembranza. È una chiesa neoromanica costruita a fine ’800 e dedicata al primo imperatore tedesco Guglielmo I. Durante la Seconda Guerra Mondiale, fu gravemente danneggiata dai bombardamenti alleati: nel 1943 e nell’aprile 1945, le bombe la ridussero a un rudere, di cui rimase solo il troncone della torre campanaria ovest. Nel dopoguerra, la Berlino Ovest in ricostruzione doveva decidere se abbattere quel che restava della chiesa o conservarlo. Nel 1956, si pensò di demolirla completamente per far posto a una nuova moderna; ma la popolazione berlinese insorse, inviando centinaia di lettere e protestando per salvare le rovine. I berlinesi sentivano che quel “dente cariato” (come veniva soprannominata la torre monca) era parte della loro identità e doveva restare come memoriale degli orrori bellici. Sioptò per una soluzione mista: l’architetto Egon Eiermann costruì (tra il 1959 e il 1963) una nuova chiesa accanto, ma lasciò intatta la vecchia in rovina come memoriale. Oggi, nel centro di Berlino, quella torre spicca accanto al nuovo edificio ottagonale dalle vetrate blu: antico e moderno, distruzione e ricostruzione, fianco a fianco. All’interno del rudere, trasformato in una cappella commemorativa, vi sono mosaici danneggiati, statue mutilate e targhe che raccontano la storia del monumento. La Gedächtniskirche è diventata il simbolo della volontà di pace di Berlino: nel2017, di fronte ad essa, i cittadini posero fiori e candele dopo un attentato terroristico, a indicare che quel luogo rappresenta la memoria del dolore e la resilienza della città. Come ha osservato uno storico, “l’edificio è stato preservato come simbolo della guerra e della distruzione”. Inoltre, la vecchia chiesa continua a ospitare cerimonie e funzioni commemorative, a ribadire la sua funzione viva. Nonostante le sfide strutturali (la torre ha una base instabile e richiede restauri per non collassare), la volontà è di mantenerla in eterno. Per i berlinesi, quella rovina rappresenta “un’epoca di guerra e distruzione da evitare” – un pensiero che richiama l’intento della Cupola di Hiroshima.
Un caso simile in Gran Bretagna: le rovine della Cattedrale di Coventry. Fu devastata dai bombardamenti aerei tedeschi nel 1940, e la sua cattedrale gotica fu ridotta a un guscio senza tetto. Dopo la guerra, invece di rimuovere i resti, la città decise di conservarle come memoriale, e costruire una nuova cattedrale moderna accanto. Oggi le mura medievali di Coventry, annerite dalle fiamme, si ergono accanto alla nuova. Dentro la navata a cielo aperto, le travi di legno cadute dal tetto formano una croce sull’altare di macerie, e sul muro dell’abside rimaste spiccano incise in oro le parole: “FATHER FORGIVE”– “Padre perdona”. Quella scritta, voluta dal clero locale, trasforma le rovine in un luogo di riconciliazione: non solo memoria della sofferenza inglese, ma perdono verso il nemico e auspicio di pace. La “vecchia” cattedrale è uno spazio di contemplazione, dove ogni anno si tengono cerimonie commemorative e preghiere per la pace, spesso con delegazioni di città un tempo nemiche. È il caso di Dresda in Germania, anch’essa devastata dai bombardamenti alleati: Coventry e Dresda, accomunate dalla stessa tragedia, sono gemellate nella riconciliazione. Anche a Dresda, la Frauenkirche barocca – ridotta a rudere nel 1945 – fu lasciata in macerie per decenni come monito. Solo dopo la riunificazione tedesca, negli anni ’90, si decise di ricostruirla pietra su pietra, reimpiegando le originali bruciacchiate recuperate: oggi la Frauenkirche mostra sulla sua facciata le macchie scure di quelle annerite dalla guerra, integrate nella nuova muratura come segni della sua storia.
Esempi come Oradour, Berlino, Coventry e Dresda, insieme ad Auschwitz e il Muro di Berlino, evidenziano un principio comune: la volontà di preservare la memoria attraverso la rovina. Invece di cancellare e dimenticare, comunità diverse hanno scelto di conservare e tramandare. Ogni rovina porta una storia di sofferenza e una lezione per il futuro. Come a Hiroshima la Cupola ammonisce sui pericoli dell’era nucleare, a Oradour le case bruciate ammoniscono sulle atrocità dei totalitarismi; la chiesa mutilata di Berlino ammonisce sulle devastazioni della guerra totale; le mura sventrate di Coventry ammoniscono sul costo umano dei conflitti e proclamano il valore del perdono.
Le rovine sono diventate luoghi di pellegrinaggio laico. La gente vi si reca per capire, provare empatia, pregare o riflettere. Sono spesso austeri, privi di orpelli: il loro potere comunicativo sta nell’essenzialità ferita. Vedere gli effetti della violenza – un edificio sventrato o un villaggio congelato nelle sue ultime ore – crea un impatto che nessun libro di storia può eguagliare. È un’esperienza sensoriale oltre che intellettuale: si cammina tra le rovine, si sente l’aria umida, si sfiorano le superfici ruvide, ci si immedesima in chi le vide formarsi in un momento decisivo. Questo coinvolgimento rende i memoriali in rovina efficaci nel trasmettere la memoria alle nuove generazioni.
La Cupola della Bomba Atomica di Hiroshima svetta nel centro di una città moderna. Attorno a lei scorrono auto, biciclette e turisti con smartphone. La vita di Hiroshima è andata avanti, fiorendo tra palazzi, negozi, giardini e monumenti di pace. Eppure quella Cupola rimane a ricordare ciò che non deve mai più accadere. Vederla, affacciata sul fiume, con gli alberi verdi del Parco della Pace intorno, suscita un sentimento difficile da descrivere: un misto di emozione, rispetto quasi sacro e speranza. Emozione per le vite spezzate che quel rudere rappresenta; rispetto per la scelta di conservarlo; speranza che il suo monito sia ascoltato.
In un’epoca in cui la distanza dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale aumenta, monumenti come la Genbaku Dome di Hiroshima svolgono un ruolo fondamentale. Sono ancore della memoria: ci collegano al passato affinché possiamo orientare il futuro. Ci mostrano fin dove può spingersi l’autodistruzione umana, ma anche come da quelle ceneri possiamo trarre un insegnamento di pace. L’architettura ferita della Cupola parla un linguaggio universale, più forte di qualsiasi traduzione: chiunque, di qualunque cultura, intuisce il suo significato. È l’urlo muto delle pietre, che valica confini e lingue.
Nella narrazione della Cupola, ci sono capitoli di orrore e rinascita morale. Hiroshima ha trasformato la devastazione in un messaggio di pace. Un sopravvissuto ha detto, “Bisogna porre fine alle armi nucleari, se vogliamo un mondo in pace”. Quelle parole, pronunciate da chi porta le cicatrici dell’esplosione, risuonano nelle mura sbrecciate della Cupola. Ogni crepa sembra pronunciarle, ogni contorno contro il cielo sembra scandirle.
Avvicinandosi oggi alla Cupola, magari al tramonto, si ha l’impressione di trovarsi di fronte a un anziano sopravvissuto che racconta la sua storia ai più giovani. Sta a noi ascoltare. Resterà lì, anno dopo anno, a parlare senza voce. Finché esisterà, ricorderà al mondo la tragedia del 1945 e il dovere della memoria attiva. Perché, come recita il cenotafio vicino, “anche le anime riposino in pace, possiamo far sì che siano da monito a non ripetere lo stesso errore”. E la Cupola, ferita ma indomita, continua a raccontare quell’errore, affinché l’umanità non lo commetta mai più.
Nel mio lavoro mi capita spesso di riflettere sul senso del restauro: cosa restaurare, cosa lasciare com’è, cosa raccontare attraverso le scelte architettoniche. La Cupola di Hiroshima mi ha insegnato che esiste un tipo di architettura che va oltre la funzione o la bellezza: un’architettura etica. Lì, ogni crepa è un ricordo, ogni mattone annerito è una voce. Non c’è bisogno di aggiungere nulla, né di togliere. La sua forza è proprio nel suo essere imperfetta, incompiuta, dolente.
La Cupola della Bomba Atomica, lasciata in piedi, è oggi un monumento che non cerca consenso, ma coscienza. Insieme al Museo della Pace e alla Fiamma accesa, testimonia che la rovina, custodita con cura e verità, può diventare un’architettura etica.Camminando tra i pannelli, si legge la voce di chi ha visto l’inimmaginabile. Una sopravvissuta, Yoshiko Kajimoto, scrive:
“Non voglio che nessuno al mondo provi ciò che ho provato quel giorno.Per questo ho deciso di raccontare. Anche se è difficile.”
Ricordare fa male, ma è l’unico modo per non dimenticare. Oggi, a ottant’anni da Hiroshima, possiamo vedere quellaCupola non come una reliquia del passato, ma come un ponte tra verità e speranza. Conoscere vuol dire evitare. Lamemoria è la cosa più importante da tramandare.
Io sono Vincenzo Biancamano, e questo è il podcast Il Restauro Architettonico.Vi invito a guardare su RaiPlay lo speciale di Alberto Angela su Hiroshima e Nagasaki, che completa la nostra riflessione.Alla prossima puntata.
Fonti:
- Hiroshima Peace Tourism, The Atomic Bomb Dome (Former Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall).
- S. Clucher, Hiroshima, dalla bomba atomica al museo della pace – Japan Travel (JNTO).
- UNESCO World Heritage Centre, Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome).
- S. Al-Bayati, The Re-Making of Hiroshima as Peace Memorial City after the Bomb – SAH Blog (2023).
- K. Tange, Hiroshima Peace Memorial Park and Museum – WikiArquitectura.
- M. Solly, Nine Eyewitness Accounts of Hiroshima and Nagasaki – Smithsonian Magazine.
- F. Merlo, Testimonianza di Michiko Kono, sopravvissuta di Hiroshima – Vatican News.
- R. Steves, Oradour-sur-Glane: France’s Ghost-Town Memorial.
- Kaiser Wilhelm Memorial Church (Gedächtniskirche) – Ruin Value, Ohio State Univ..
- Imperial War Museums, Coventry Cathedral Ruins.