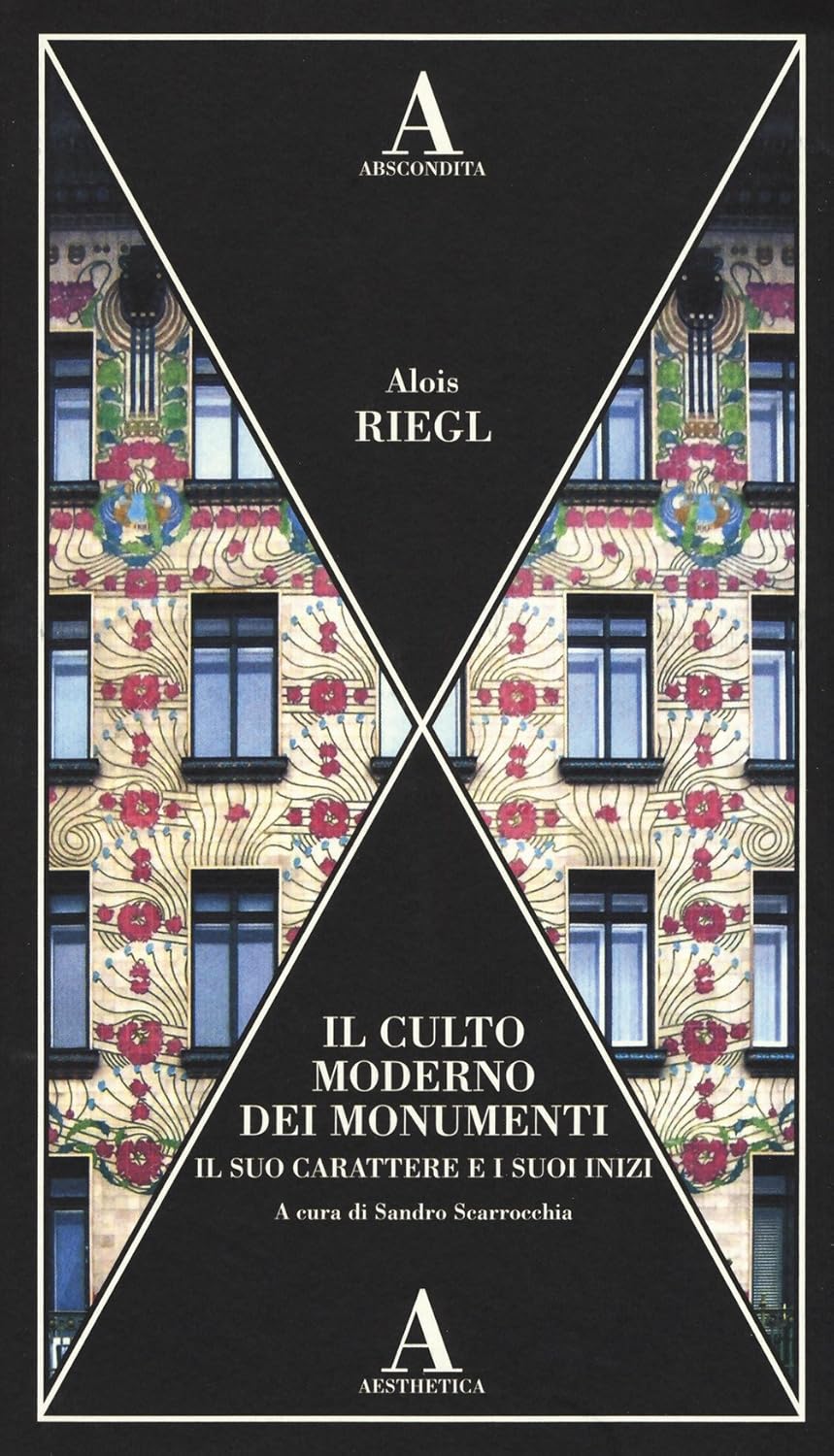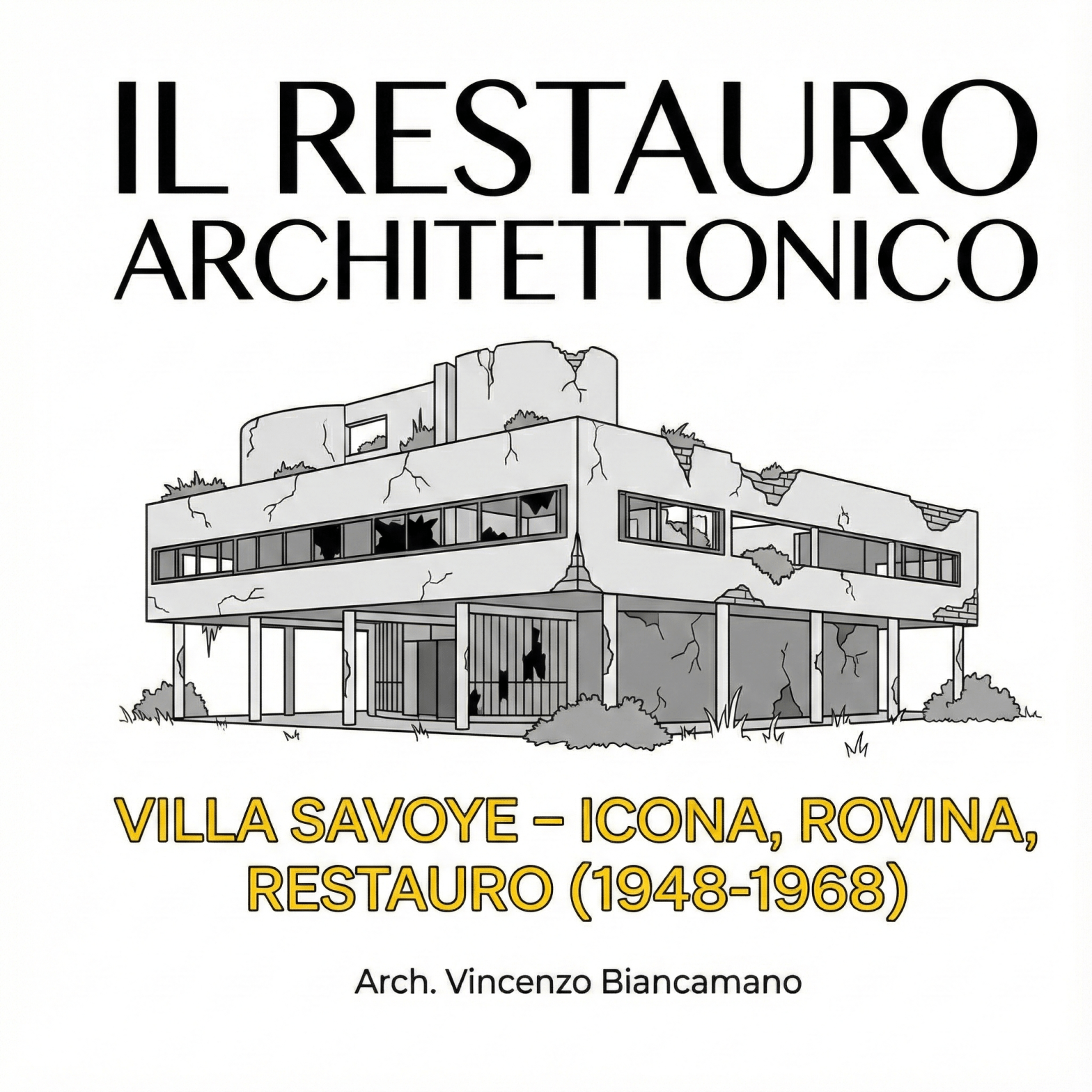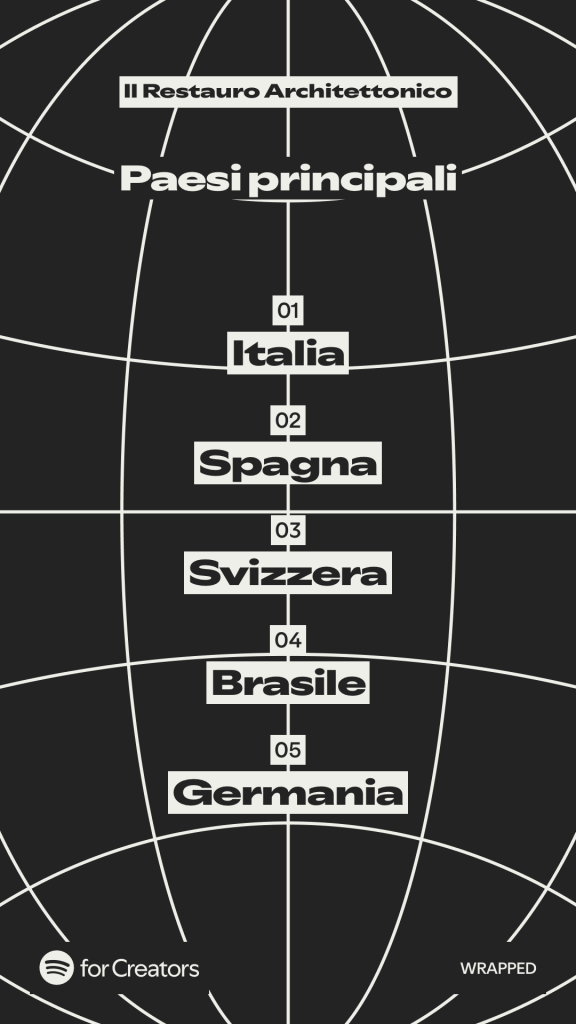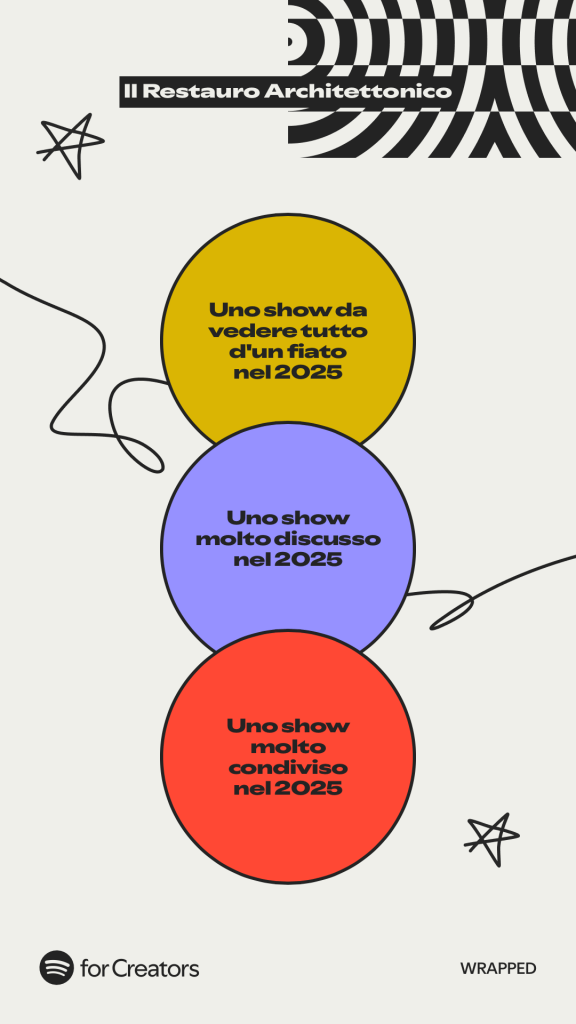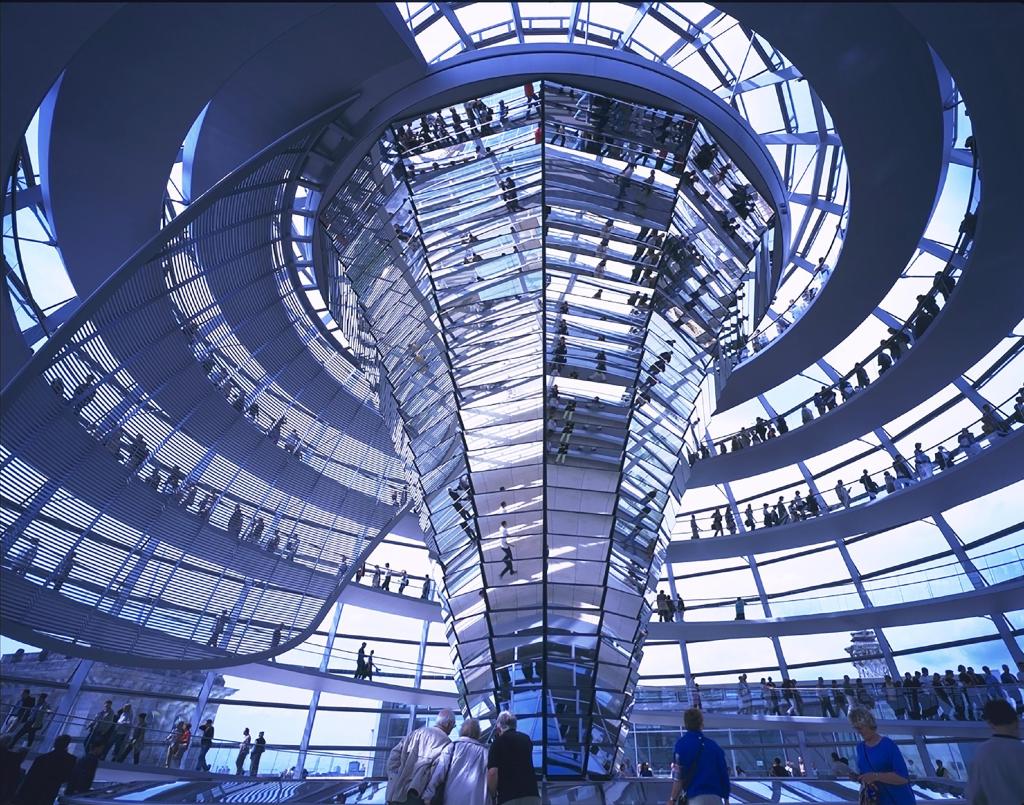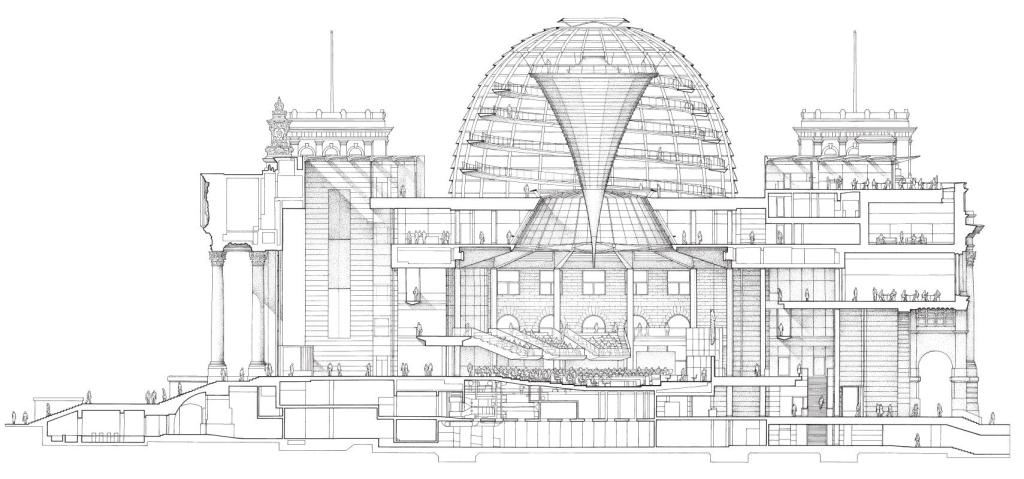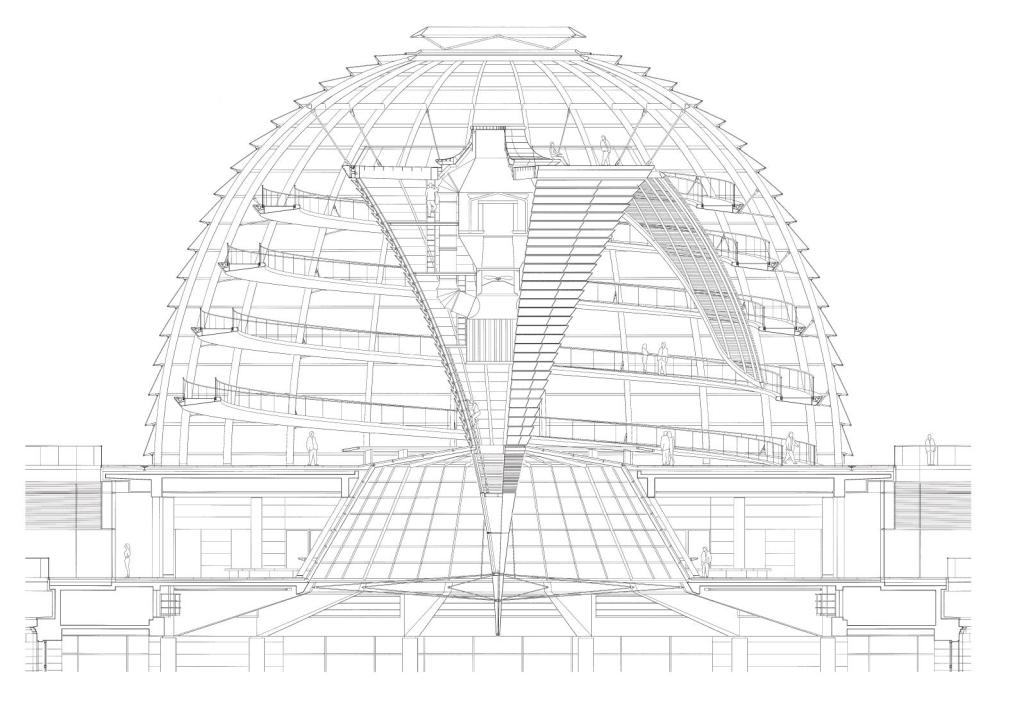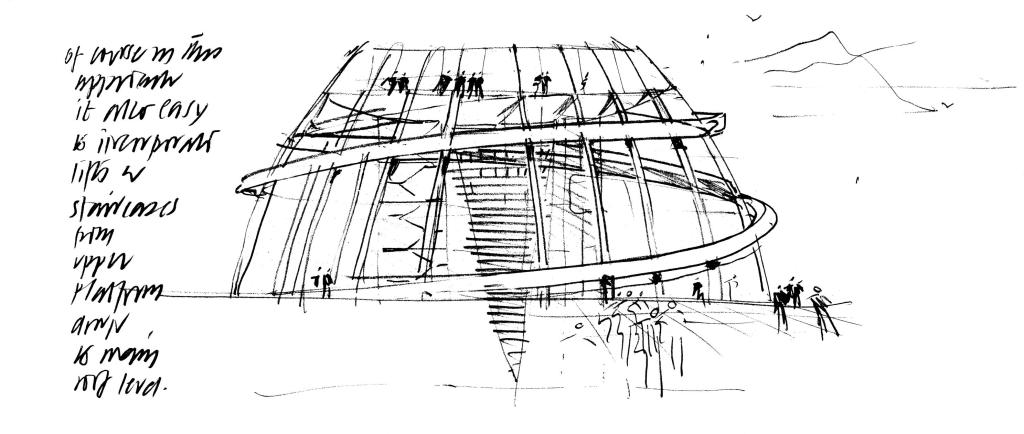Abstract
L’articolo analizza Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi (1903) di Alois Riegl, testo fondativo della teoria della tutela contemporanea. Attraverso una lettura critica del saggio, vengono chiariti il significato di “culto moderno” dei monumenti e la distinzione tra monumenti intenzionali e non intenzionali, evidenziando come il valore monumentale non risieda nell’oggetto in sé ma nell’attribuzione culturale operata dall’osservatore moderno. Il contributo approfondisce la celebre tassonomia riegliana dei valori – storico, d’età (Alterswert), d’arte, d’uso e commemorativo – mettendo in luce le antinomie e le tensioni che ne derivano nella pratica della conservazione. Ne emerge una concezione del restauro come processo di mediazione critica, fondato su una gerarchia dei valori variabile e contestuale, che rifiuta ogni criterio assoluto. L’attualità del pensiero di Riegl viene infine ricondotta al suo carattere metodologico: un dispositivo decisionale ancora centrale per comprendere e governare la complessità del patrimonio architettonico tra passato e presente.
Benvenuti in un nuovo episodio del podcast “Il restauro architettonico”. Io sono Vincenzo Biancamano e oggi approfondiamo uno dei libri più famosi del restauro : “Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi”(1903) di Alois Riegl. Ci concentreremo esclusivamente sul testo riegliano. L’obiettivo dell’analisi è chiarire cosa Riegl intenda per “culto moderno” dei monumenti e come da questa nozione derivi una tassonomia dei valori alla base della tutela contemporanea. La tesi è che la pluralità di quelli individuati – valore d’età (Alterswert), storico (historischer Wert), d’arte relativo/assoluto (Kunstwert relativ/absolut), d’uso (Gebrauchswert) e commemorativo (Erinnerungswert) – genera antinomie strutturali e una gerarchia variabile tra i monumenti, costituendo il nucleo del “moderno” in materia di conservazione.
Che cos’è il “culto moderno” dei monumenti?
Riegl definisce culto moderno l’attitudine contemporanea (inizio Novecento) di venerare e tutelare i monumenti del passato indipendentemente dalla loro funzione. È un culto “moderno” in contrasto con le pratiche antiche: se in epoche precedenti solo determinati oggetti – tipicamente i monumenti eretti per ricordare eventi o personaggi – erano venerati,nell’epoca moderna l’interesse si estende a tutti i manufatti storici e artistici. Quando si parla di culto moderno, Riegl nota che «non pensiamo quasi mai ai monumenti “intenzionali”, ma ai “monumenti storici e artistici”», ovvero a tutte le opere del passato con valore culturale. Il culto è “moderno” perché nasce da idee recenti sul valore dell’arte e della storia sviluppatesi nel XIX secolo, alimentato da una nuova sensibilità del pubblico (Publikum) verso i monumenti. Non è più ristretto a eruditi o committenti privilegiati, ma coinvolge le masse e le istituzioni statali preposte alla tutela (la protezione giuridica). Riegl evidenzia come fino a pochi decenni prima “le masse” fossero interessate quasi solo al nuovo e al funzionale, mentre la comprensione dei valori storico-artistici richiedeva educazione . La mentalità tradizionale attribuiva valore a ciò che appariva nuovo e integro, vedendo nelle opere la “vittoriosa attività” dell’uomo e rifuggendo i segni di degrado della natura. Il moderno culto insegna ad apprezzare anche l’antico, il frammentario e la patina del tempo. In questo senso, esso rappresenta un cambiamento epocale: «come l’Ottocento fu il secolo del valore storico, così il Novecento sembra destinato a diventare il secolo del valore dell’antico. Per ora, tuttavia, ci troviamo ancora nella fase di transizione». La diffusione di tale culto, sostenuto da un maggiore coinvolgimento pubblico e da leggi di tutela, modifica lo sguardo contemporaneo sul passato e impone nuovi criteri per la conservazione dei monumenti (maggiorerispetto per l’aspetto vetusto e per tutte le tracce storiche, contrariamente ai restauri integrativi del secolo precedente).
Secondo Riegl, il “monumento” può essere intenzionale e non intenzionale.
Per Riegl, il concetto di monumento (Denkmal) va inteso in senso ampio, distinguendo tra quelli intenzionali e non. Unmonumento intenzionale è «un’opera della mano dell’uomo, creata allo scopo determinato di conservare sempre presenti e vivi singoli atti o destini umani… nella coscienza delle generazioni future». Le opere commemorative erette in memoria di eventi o persone (statue, iscrizioni, edifici, ecc.) rientrano in questa categoria, concepite per trasmettere ai posteri il ricordo di qualcosa. La loro intenzionalità (Erinnerungswert absichtlicher in termini di valore) è esplicita e riconosciuta: ad esempio un monumento funebre o una colonna celebrativa possiedono per definizione valore di memoria intenzionale. Tali “volontari” esistono fin dai tempi antichi e continuano a essere prodotti nell’era moderna.
Riegl evidenzia i monumenti non intenzionali: opere del passato non destinate alla memoria, ma riconosciute nel tempo come testimonianze e valorizzate dai posteri. Si concentra sui “involontari” – storici e artistici – nel culto moderno. Qualsiasi costruzione, manufatto o opera d’arte passati può diventare un monumento se attribuiamo un valore storico, artistico o affettivo. In altri termini, il carattere monumentale non risiede nell’oggetto, ma nell’attribuzione di valoredell’osservatore moderno. Un edificio antico può non essere nato come monumento; oggi lo consideriamo tale in virtù dei valori di cui è portatore (antichità, importanza storica o artistica). Questa distinzione implica che il riconoscimento del valore è un atto moderno: mentre il monumento intenzionale possiede un valore commemorativo di per sé (stabilito dal suo creatore), il non intenzionale diviene tale perché gli attribuiamo valori culturali. Comprendere il valore di Riegl èfondamentale per capire il culto moderno.
Tassonomia dei valori nel culto moderno.
Riegl elabora una tassonomia dei valori dei monumenti, cioè delle ragioni per cui essi possono (e devono) essere apprezzati e conservati. Riegl distingue due categorie: i valori di memoria (Erinnerungswerte), rivolti al passato, e i valori contemporanei, rivolti alle esigenze attuali. I primi comprendono il valore storico, d’età e commemorativo; i secondi includono il valore d’uso e d’arte (analizzato come valore artistico “relativo” in contrapposizione a un ipotetico assoluto). Riegl definisce ciascun valore e svolge una funzione nel quadro teorico:
- Valore storico (historischer Wert): È il valore derivante dal significato storico-documentario di un’opera. In senso lato, «si chiama storico tutto ciò che è stato e che oggi non esiste più». Ogni testimonianza del passato ha un valore irripetibile. Secondo la concezione storiografica moderna basata sull’idea di sviluppo, ogni evento o creazione umana è un “anello” insostituibile in una catena evolutiva. Il valore di un monumento consiste nel rappresentare un preciso stadio di sviluppo in un dato campo (artistico, sociale, tecnico, ecc.), collegando passato e presente. Questo valore ordina la lettura del passato perché spinge a considerare ogni opera nel suo contesto cronologico e a preservarla come documento unico di una fase storica. L’obiettivo implicito è istruire: il monumento è conservato per conoscere e ricostruire la storia. Ad esempio, un edificio medievale parla dell’architettura e della società del Medioevo; anche se non fosse esteticamente rilevante, costituisce una fonte imprescindibile. Il valore storico si applica senza eccezioni: Riegl sottolinea che ogni opera umana tangibile può rivendicare un valore in quanto testimonianza del passato. Il rischio è la tendenza a considerare il monumento solo come documento, perdendo la percezione del suo fascino. Inoltre, per isolare il monumento nella sua fase originaria, si sono effettuati restauri storicistici eliminando aggiunte posteriori per presentare un’immagine “pura” di un certo periodo. Ciò ha generato antinomie con altri valori (ad es. conflitti con il valore d’arte o d’età, quando si sacrificavano parti antiche per riportare il monumento a un presunto stato originale).
- Il valore d’età (Alterswert) è il valore derivante dall’antichità di un’opera e dai segni del tempo. Non dipende dall’importanza storica o artistica del monumento, ma dalla sensazione di reliquia di un’epoca lontana. Si manifesta nell’aspetto di rovina, nella patina delle superfici, nelle lacune e sbiaditure. Riegl osserva che anche una pergamena medievale comunica un valore di memoria attraverso la pergamena ingiallita e la sua “patina”, ossia l’aspetto vetusto e le lettere sbiadite. Il valore d’età tende a un fine estetico: la contemplazione dell’antico genera un sentimento peculiare, una sorta di melanconico piacere nel percepire la transitorietà delle cose umane. Per Riegl questo atteggiamento è tipico del moderno: nell’Ottocento avanzato e nel Novecento si apprezza la “bellezza del vecchio”, cosa prima impensabile. Ci riconcilia col passato non per ciò che ci dice (come il valore storico), ma per ciò che è: una traccia materialmente sopravvissuta alla caducità. Il suo obiettivo è commemorare il tempotrascorso, suscitando rispetto quasi religioso per l’antico. Riegl nota che i criteri per cogliere il valore dell’antico sono estremamente semplici e immediati, e «possono essere apprezzati anche da gente il cui intelletto normalmente è [poco formato], mentre «il valore storico… può essere pienamente compreso solo per via indiretta, attraverso la riflessione». In ciò il valore d’età appare “democratico” e ha conquistato il pubblico più ampio. Tuttavia, il culto esclusivo dell’antico comporta rischi: se assolutizzato, porta a glorificare il decadimento e l’obsolescenza a scapito di ogni altro valore. I fautori estremi del valore d’età proclamano che «non esiste salvezza estetica se non nel valore dell’antico», assumendo un atteggiamento intollerante verso qualsiasi intervento che possa intaccare la patina del tempo. Ciò genera antinomie con i valori che richiedono intervento umano: il valore d’età è in tensione col valore di novità (tendenza a ripristinare il monumento come nuovo) e con esigenze del valore d’uso e d’arte.
- Valore d’arte (Kunstwert) relativo/assoluto: Questo valore riguarda l’importanza estetica del monumento. Riegl distingue tra un valore “assoluto”, valido in ogni tempo secondo canoni oggettivi, e un “relativo” frutto del gusto e della volontà d’arte (Kunstwollen) di ogni epoca. La svolta moderna consiste nel rifiuto di un’estetica assoluta e atemporale: «secondo le idee d’oggi non esiste un valore artistico assoluto, ma solo uno relativo, moderno». In passato (fino a metà Ottocento) si credeva in un ideale estetico universale: nel Rinascimento si giudicavano le cattedrali gotiche “sbagliate” rispetto ai canoni classici, e le si trasformava. Oggi si riconosce che ogni epoca ha un proprio Kunstwollen, una “volontà artistica” che determina lo stile: il moderno vede nelle opere del passato un valore artistico relativo, ossia relativo al contesto culturale che le produsse, ma non meno degno di apprezzamento. Il valore d’arte relativo amplia il nostro gusto: possiamo godere esteticamente di opere di epoche e stili diversi, purché comprendiamo l’intenzione artistica originaria. Ciò implica conservare le opere nel modo più autentico possibile, perché solo così il loro valore estetico originario resta percepibile. Se un monumento ha subito alterazioni, il valore d’arte spinge a ripristinare la leggibilità estetica dell’opera: qui si aprono due approcci che Riegl discute. Il primo, legato all’ideale di valore assoluto, era il restauro stilistico integrale: si eliminavano le stratificazioni per restituire al monumento un aspetto unitario e “come nuovo” conforme al gusto originario (unendo valore storico e di novità in un’operazione di reintegrazione). Il secondo, coerente col valore d’arte relativo, è conservativo: si preserva l’opera nello stato attuale, accettando le stratificazioni storiche, perché aggiunte e trasformazioni possono avere pregio artistico in quanto espressioni di epoche successive. Riegl attribuisce al valore d’arte relativo una spinta alla conservazione non meno forte del valore d’età: il gusto moderno è in grado di apprezzare la “stratificazione” di un monumento, traendo godimento estetico dai contrasti stilistici accumulati nel tempo. L’obiettivo è estetico-contemplativo: far sì che continui a produrre un piacere nell’osservatore contemporaneo. I rischi riguardano il conflitto col valore storico (se l’esigenza estetica spinge a sacrificare testimonianze meno “belle”) e col valore d’età (ad esempio, la pulitura di un dipinto per renderlo leggibile artisticamente può diminuire la patina apprezzata dal valore d’antico). Tuttavia, la moderna mentalità relativista tende a mitigare tali conflitti: riconoscendo validità a tutti gli stili, oggi raramente chiede di distruggere parti di monumento, preferendo convivere con le tracce del tempo.
- Il valore d’uso (Gebrauchswert) è il valore legato all’utilità presente del monumento, cioè alla sua funzione pratica per la società attuale. Un edificio storico può ancora essere utilizzato (ad esempio una chiesa antica ancora officiata, un museo o un’abitazione); in tal caso possiede un valore d’uso vivo, che richiede considerazione. Riegl nota che la vita fisica e funzionale dell’opera «è la premessa per ogni vita psichica e… è più importante di quest’ultima, perché può svilupparsi anche senza vita psichica». Riegl riconosce priorità logica alle esigenze materiali: se un monumento deve continuare a servire agli esseri umani, bisogna garantirne l’agibilità e la sicurezza prima della conservazione della materia o dell’estetica. Il valore d’uso mantiene vivo il monumento nella società, evitando che diventi un oggetto morto in una teca. Il suo obiettivo è pragmatico: adattare il monumento alle necessità odierne (installare impianti, consolidare strutture, apportare modifiche) per prolungarne la fruizione. Il rischio è che tali interventi pratici contrastino con i valori di memoria e d’arte: ciò che è utile contrasta con ciò che è antico. Riegl sottolinea il conflitto tra valore d’uso e valore d’età: per rendere utilizzabile un edificio antico in sicurezza, può essere necessario alterarne lo stato di vetustà (rimuovere parti pericolanti, sostituire elementi, rinnovare materiali). Il pubblico contemporaneo comprende entrambi i valori e accetta compromessi, ma resta una tensione. Ad esempio, se in una torre medioevale usata come attrazione si tolgono alcune pietre lesionate e le si rimpiazzano con nuove, dal punto di vista storico il danno è modesto (la forma originale resta e l’antico è in gran parte salvo) ma dal punto di vista dell’età anche quelle minime sostituzioni «rappresentano una grave alterazione»perché stridono visivamente con la patina circostante. Dunque il valore d’uso è compatibile con gli altri solo entro limiti: esso impone una mediazione, pena la rinuncia all’uso se si privilegiano integralmente i valori di memoria. Nel culto moderno dei monumenti, il valore d’uso è riconosciuto, ma Riegl nota che quando l’utilità pratica cessa (monumento dismesso), prevalgono i valori storici, artistici e d’età sull’idea di riuso.
- Valore commemorativo intenzionale (Erinnerungswert): È il valore dei monumenti creati per scopi celebrativi o commemorativi. Riegl tratta questo valore separatamente, perché precede e riassume gli altri valori di memoria, pur essendo parte del patrimonio tutelato. Il culto antico dei monumenti era rivolto a quelli intenzionali (mantenimentodi statue onorarie, epigrafi, monumenti pubblici). Nel culto moderno, tale valore ha perso centralità a favore di valori non intenzionali come l’età e la storicità. Tuttavia, Riegl lo include nella tassonomia per completezza: un monumento nato per commemorare ha un evidente valore di memoria che permane nel tempo (esempio: una lapide ricorda il caduto a cui è dedicata). La funzione del valore commemorativo è celebrativa ed educativa: mantenere vivo il ricordo di eventi o persone esemplari per la collettività. L’obiettivo è spesso morale o patriottico (glorificazione, identità culturale). In termini di conservazione, il valore commemorativo intenzionale può spingere a restauri per mantenere intatta la capacità simbolica del monumento. Ad esempio, restaurare periodicamente una statua cittadina importante per la memoria collettiva affinché continui a “parlare” alle nuove generazioni. I rischi di questo valore, per Riegl, non vengono discussi ampiamente, poiché egli dà per scontato che i monumenti intenzionali continuino ad essere curati (già oggetto di tutela tradizionale). Si può ipotizzare un conflitto con il valore d’età: per mantenere leggibile il messaggio commemorativo, si interviene rinnovando il monumento (ridipingendo iscrizioni, restaurando parti mancanti), potenzialmente in contrasto con la patina e l’autenticità materiale. Riegl suggerisce che nella mentalità moderna i monumenti intenzionali siano meno problematici, perché il loro valore è chiaro e univoco. La vera sfida sono quelli non intenzionali con la loro pluralità di valori.
Antinomie e gerarchie tra i valori
La coesistenza di molteplici valori in ogni monumento genera inevitabilmente antinomie, ovvero contraddizioni e conflitti. Riegl analizza queste tensioni interne, evidenziando come il culto moderno non possa risolversi in un criterio unico, ma debba mediare caso per caso tra istanze contrapposte. I principali conflitti individuati nel testo sono:
- Antinomia tra valore d’età e valore di novità (vecchio vs nuovo): È il contrasto più evidente. Il primo richiede di accettare il monumento nel suo stato attuale, anche se degradato, valorizzando l’aspetto vetusto e la patinaaccumulata. Il secondo (non formalizzato da Riegl come categoria a sé, ma presente come tendenza opposta) spinge a intervenire per far apparire l’opera come appena realizzata, eliminando le tracce del tempo. In passato i restauri ottocenteschi privilegiavano il “nuovo”: si consolidavano e rinnovavano radicalmente le strutture per restituire un’immagine integra e fresca (rifacimenti stilistici). Il culto moderno, con il suo favore per l’antico, ribalta in parte questa tendenza, ma la tensione resta aperta. Principio chiave: ogni intervento di restauro deve trovare un equilibrio tra conservare la patina (valore d’età) ed evitare il degrado ulteriore senza falsificare il monumento con eccessi di nuovo. In altre parole, il moderno rifiuta sia l’abbandono alla rovina, sia il rifacimento totale: tra questi estremi si colloca la pratica conservativa attuale, che rallenta il decadimento senza azzerarlo.
- Antinomia tra valore d’uso e conservazione: Se un monumento antico è ancora destinato a un uso, l’adattamento funzionale può confliggere con la volontà di conservarne integrità e atmosfera. Riegl fa l’esempio della necessità di tutelare la salute e sicurezza in un edificio abitato: questo «rende impossibile un rigoroso rispetto del valore di antichità», poiché bisognerà inserire rinforzi, impianti o barriere che alterano l’aspetto originario. Secondo Riegl il valore d’uso non può essere ignorato – la vita fisica dell’opera viene prima – ma va soddisfatto minimizzandol’impatto sugli altri valori. Quando l’uso attivo compromette i valori culturali, si può decidere di destinare il monumento a un uso più compatibile o dismetterlo (trasformandolo in monumento puramente storico-artistico visitabile). La gerarchia qui è variabile: prevale l’uso per monumenti vitali alla comunità (es. edifici religiosi in funzione, centri storici abitati), mentre prevale la conservazione per quelli la cui funzione è sostituibile o meramente rappresentativa.
- Antinomia tra valore storico e valore d’arte: Questi valori, che Riegl considera pilastri del culto moderno, possono divergere. Il primo considera l’opera come documento e preferisce conservarla con tutte le stratificazioni e trasformazioni, perché fanno parte della storia. Il secondo, specie se inteso come godimento estetico, tende a privilegiare l’unità formale e la leggibilità. Un tipico conflitto è: un edificio ha parti aggiunte in epoche diverse, importanti per la storia ma dissonanti sul piano stilistico. Che fare? Nel XIX secolo si sceglieva di rimuovere le aggiunte per ripristinare la purezza originaria, favorendo l’arte “originaria” a scapito della stratificazione. Riegl, col suo approccio moderno, suggerisce che nessuno dei due valori abbia diritto assoluto: va trovata una sintesi equilibrata. La tutela moderna deve considerare l’importanza storica di ogni fase e l’effetto estetico complessivo,cercando di non sacrificare irreversibilmente né la verità né la bellezza percepibile. La soluzione è conservare tutto il conservabile, distinguendo visivamente le parti per non falsificare la percezione o spiegando al pubblico la complessità storica, piuttosto che semplificare l’opera eliminando ciò che disturba l’occhio.
- Il ruolo della patina e la dialettica conservazione/restauro: La patina – alterazioni superficiali dovute al tempo (scolorimento, ossidazione, usura) – è elevata da Riegl a simbolo del valore d’età. Egli afferma che per il culto dell’antico è intoccabile, mentre per l’approccio tradizionale (orientato al nuovo o all’arte assoluta) andrebbe rimossa perché segno di degrado. Da questa diversa valutazione derivano scelte opposte: non pulire un dipinto antico per lasciarne la velatura brunita, oppure far risaltare i colori originari; consolidare un rudere mantenendone la superficie erosa, oppure integrarlo ricostruendo le parti mancanti. Principio chiave: Riegl propugna che l’autentica tutela moderna riconosce un diritto di cittadinanza alla patina, portatrice di valore d’età, e quindi non va cancellata completamente. Il restauro deve essere “sensibile”: ammette solo interventi che non distruggano l’aura di vetustà che distingue un monumento nuovo da uno antico. Questo non significa lasciare deperire i materiali fino al collasso (Riegl è chiaro che la tutela deve prevenire il periculum in mora, ossia evitare il crollo), ma evitare restauri che rendano l’oggetto “come nuovo”, negando il trascorrere del tempo.
Riegl evidenzia che la gerarchia dei valori è variabile e contestuale: non esiste una scala fissa che assegni sempre priorità allo stesso valore. Il tratto distintivo del moderno è l’abbandono di un dogma unico (come l’assoluto artistico o la sola utilità). La modernità riconosce la pluralità e relatività, ammettendo che in alcune circostanze prevalga uno, in altre un altro, secondo un giudizio critico caso-per-caso. In un rudere archeologico ad alto valore d’età e storico, privo di uso, sarà logico privilegiare la conservazione com’è (anche a costo di rinunciare a ricostruzioni estetiche); in un palazzo storico adibito a sede istituzionale, si accetteranno compromessi per garantire l’uso, salvaguardando le parti antiche. Questa flessibilità è per Riegl l’essenza del culto moderno: non si tratta di anarchia soggettivistica, bensì di un approccio decisionale informato da tutti i valori.
Il “moderno” come dispositivo decisionale
Per Riegl, la pluralità dei valori del monumento non è un catalogo teorico, ma uno strumento pratico per decidere gli interventi di tutela. Il saggio è scritto in preparazione di una legge austriaca di tutela monumentale, quindi è concreto nel trarre regole operative. Il “moderno” è un dispositivo per bilanciare i valori: il passato adottava soluzioni unilaterali (distruggere il vecchio per fare spazio al nuovo, o congelare tutto), la modernità impone di ponderare. Le autorità devonovalutare quale valore abbia preminenza e agire di conseguenza, tenendo presenti gli altri per minimizzare le rinunce. Sesi restaura un edificio gotico, si deciderà fino a che punto ripristinarne l’unità stilistica (valore d’arte) senza falsificare le aggiunte barocche (valore storico) e senza rimuovere la patina (valore d’età); se si deve continuare a utilizzare l’edificiocome chiesa, si faranno adattamenti (valore d’uso) purché reversibili e rispettosi. Riegl non fornisce “ricette” fisse, ma struttura un metodo: riconoscere tutti i valori, capire le loro richieste e contrasti, scegliere l’azione che soddisfa il valore prevalente limitando il sacrificio degli altri. Il moderno culto dei monumenti è un processo dialettico e integrativo. Ha anticipato molte odierne regole del restauro (minimo intervento, distinguibilità delle aggiunte, reversibilità), ma Riegl le formula dal proprio sistema di valori, senza “carte” esterne. Il risultato è un quadro di riferimento dove la decisione tecnica è giustificata teoricamente: se non reintegro un affresco lacunoso, attribuisco maggior peso al valore d’età e storico; se integro con tratteggio, è per un compromesso tra esigenze d’arte e rispetto dell’autenticità (patina).
Riegl chiama modernità la variabilità dei criteri. Sottolinea che la mentalità moderna ha superato l’idea di un singolo metro di giudizio (né l’utile puro, né il bello assoluto, né la sola erudizione storica): il moderno è pluralista e relativista.Di conseguenza, la gerarchia dei valori è dinamica: nessuno occupa permanentemente il vertice, ma ciascuno può diventare decisivo quando necessario. Questa è forse la lezione più importante del saggio di Riegl per la pratica conservativa. Possiamo riassumere alcuni principî chiave dalla pluralità nel culto moderno riegliano:
- Nessun valore è assoluto. Tutti (storico, d’età, d’arte, d’uso, commemorativo) coesistono e devono essere considerati. Il moderno rifiuta di sacrificare a priori uno solo in nome di un dogma.
- La conservazione è un compromesso. Il restauro moderno deve mantenere quanto più valore possibile, evitando interventi che soddisfino un valore distruggendone un altro.
- La gerarchia dei valori è caso-specifica. Quale valore prevalga dipende dal monumento e dal contesto (es. rovina disabitata vs edificio utilizzato). Non esiste una gerarchia fissa, quindi è necessaria un’analisi critica per ogni intervento.
- Il valore dell’antico impone il limite etico del restauro: non si deve azzerare il passato di un monumento. Ogni intervento deve rispettare l’autenticità materiale e della patina, riconoscendo un dovere verso le generazioni future.
- Il valore storico richiede veridicità documentaria: ogni parte, anche deformata dal tempo, ha un valore come documento. Le aggiunte storiche non vanno rimosse senza ragione, a meno che non confliggano con altri valori superiori.
- Il pubblico contemporaneo va educato alla pluralità dei valori. Poiché il culto moderno è diffuso, occorre far comprendere le ragioni delle scelte conservative. Riegl implica la necessità di sensibilizzare la società che un monumento può essere importante per molte ragioni e che la tutela agisce nell’interesse generale (interesse pubblico) e non di parte.
Alois Riegl espone un impianto teorico in Il culto moderno dei monumenti che spiega perché e come preservare i monumenti nell’era moderna. I valori identificati – storico, d’età, d’arte, d’uso e commemorativo – costituiscono il cuore dell’approccio conservativo, in contrapposizione all’indifferenza distruttiva di epoche passate e al fanatismo di congelare tutto. Riegl mostra che la compresenza di valori differenti fa del monumento un oggetto culturale complesso, la cui tutela non può ridursi a semplici ricette. Il suo lessico (termini come Alterswert, Kunstwollen, patina, Denkmal) è diventato parte del dibattito sul restauro, e la sua logica pluralista ha anticipato principi oggi acquisiti.
Riegl ha messo in luce le contraddizioni della tutela, un merito fondamentale. Le contraddizioni sono: conservare l’aspetto di antichità vs. garantire l’uso presente; rispettare tutte le fasi storiche vs. valorizzare l’unità estetica; lasciare agire il tempo vs. intervenire per impedire il degrado. Invece di negarle, Riegl le assume come parte del “moderno” e fornisce uno schema per gestirle, inaugurando una mentalità di mediazione. La gerarchia variabile dei valori è il punto di forza e il limite della teoria: se tutto dipende dal caso specifico, c’è il rischio di arbitrarietà. Riegl scongiura tale rischio confidando in un approccio scientifico e nel confronto pubblico: la sua idea di interesse implica che le decisioni siano prese per il bene comune e con trasparenza. Un altro limite è che non offre esempi concreti nel testo (per scelta di immanenza teorica), lasciando aperta la questione di come applicare in pratica la variabilità dei valori. Questo aspetto fu approfondito da altri teorici, ma resta un’apertura: Riegl ci dà il quadro concettuale, non un manuale operativo.
Il culto moderno dei monumenti è il fondamento teorico della tutela dei beni culturali, poiché afferma che il “moderno” non è un singolo valore, ma la convivenza di molti. L’attualità di Riegl sta nell’aver compreso che ogni monumento ha molteplici significati per diverse comunità e generazioni, e che il compito della tutela è negoziare il rispetto reciproco. Questo approccio, interno al testo di Riegl ma lungimirante, ha aperto la strada a una concezione del patrimonio come dialogo tra passato e presente, dove la decisione critica – illuminata dalla conoscenza storica, dalla sensibilità estetica e dal senso pratico – deve evitare l’idolatria acritica del passato e la sua cancellazione irrispettosa.Riegl, con il suo lessico e la sua logica, ci consegna un “dispositivo” intellettuale ancora centrale: il culto, per essere moderno, deve continuamente ricomporre l’unità di senso dei monumenti a partire dalla pluralità irriducibile dei loro valori.
Bibliografia: